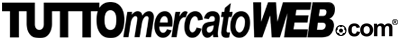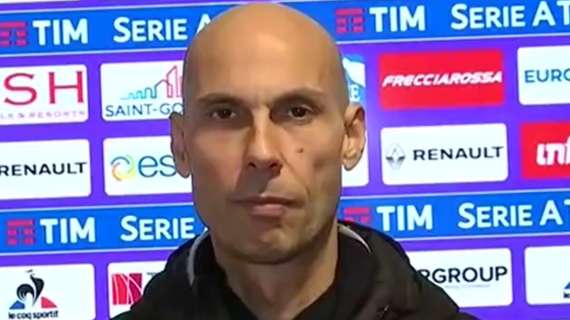Fiorentina-Juventus, una partita “capitale”
 TUTTOmercatoWEB.com
TUTTOmercatoWEB.comPrimo tempo a Firenze da cancellare dall'almanacco, illudendo i tifosi qualche secondo prima dell’intervallo con un gol fortunoso di Kostic, dopo un rimpallo di sedere del conterraneo Vlahovic. Imbarazzante nel più profondo del significato. Dallo spagnolo del XVI secolo "embarazo", "ingombro materiale" o "molestia. Siamo stati emotivamente molestati. Secondo tempo: fuochi fatui di speranza soltanto per non aver perso la partita. Troppo poco, pochissimo, quasi niente. Un vecchio adagio recitava... chi di speranza vive, disperato muore. È domenica, l’inverno è arrivato prepotente, non ci immalinconiamo oltremodo, già il sabato sera ha lasciato freddi grigi strascichi, pensiamo ad altro, proviamoci.
Spesso si sente dire che l’acerrima rivalità, molto vicina ad un odio sportivo – ossimoro da me sempre contrastato e avversato -, tra i tifosi del Napoli e quelli della Juventus abbia avuto origine nientemeno dalla storica “Questione meridionale” e dalla guerra tra i Savoia e i Borbone. E allora perché non addebitare anche alla Storia che sto per raccontare, - dove i torinesi rimasero molto ma molto male, e i fiorentini non di meno -, anche la grande competizione che vi è tra i bianconeri di Torino e i viola di Firenze?
Il 27 marzo 1861, dopo il discorso di Cavour, la Camera proclamò Roma capitale d'Italia: in realtà, lo diventò solo nel 1871 quando i Savoia vi si trasferirono con l'intera corte. Ma prima di approdare alla Città Eterna, l'Italia unitaria ebbe, tra rivolte e invidie, altri due cuori politici: Torino e Firenze.
«Per vedere Torino nel suo più bell'aspetto, bisogna vederla in occasione di una di quelle grandi feste nazionali, in cui accorrono qui italiani d'ogni provincia. Il popolo torinese è tutto in giro, e in quei giorni rivive anch'esso in quel bel tempo, che par già tanto lontano». Il nostalgico che scrisse queste parole in un libro intitolato Le tre capitali (1897) è Edmondo De Amicis. E il passato "tanto lontano" è quello della nascita dell'Italia unitaria: il tempo in cui, il 18 febbraio 1861, fu convocato per la prima volta il neoeletto parlamento italiano e quello in cui, il 17 marzo dello stesso anno, Vittorio Emanuele II fu proclamato re d'Italia "per grazia di Dio e volontà della nazione".
Sfondo di quegli eventi fu Torino, prima capitale d'Italia.
Torino fu scelta grazie alla sua tradizione di potere come capitale del Regno di Sardegna e al legame con la dinastia sabauda, protagonista dell’unificazione. Inoltre, la sua posizione strategica a nord, vicino a Francia e Svizzera, la rendeva un punto di riferimento per la diplomazia e le relazioni internazionali. Tuttavia, la scelta fu temporanea, poiché regioni come il Veneto e Trentino non erano ancora state annesse. Per di più, Roma era ancora sotto il controllo dello Stato Pontificio.
Per secoli, fino all'epoca napoleonica, un austero centro burocratico, nell'Ottocento Torino divenne una città di grandi viali bordeggiati da palazzi aristocratici e dimore borghesi, illuminata dal 1838 dall'azzurrognola luce a gas, popolata lungo i portici da rinomati caffè letterari, circondata nei dintorni da ville e palazzine di caccia. Una piccola Parigi. In seguito alla concessione dello Statuto albertino (1848) e alle due guerre sostenute dalla monarchia sabauda contro l'Austria, Torino si era guadagnata il titolo di capitale morale degli indipendentisti. Uffici, strade e palazzi. L'opera diplomatica di Cavour le aveva tolto di dosso l'antica aria di isolamento, europeizzandola, mentre la schiera di patrioti che, esuli, vi avevano trovato ospitalità, l'avevano italianizzata. Con il nuovo ruolo di capitale, a partire dal 1861 Torino fu nuovamente trasformata e risanata, sistemando funzionari pubblici, ministeri con i loro dipendenti e decine di altri uffici governativi: molte strade furono pavimentate e spuntarono nuovi meravigliosi palazzi. Nonostante l'orgoglio dei suoi abitanti, tutti sapevano che Torino non sarebbe stata capitale per sempre.
Scartata la candidatura di Napoli, fu scelta – anche su pressione di Napoleone III – Firenze, capitale del Regno d’Italia, avvicinandosi pian piano all’obiettivo. I torinesi non gradirono. Il 21 settembre 1864 fu presa di mira la sede della Gazzetta di Torino, il quotidiano allora più diffuso in città, che nel dare la notizia aveva scritto che sarebbe stato di consolazione per i concittadini sapere che il re sarebbe tornato di tanto in tanto a far loro visita. Sciolta con la forza quella dimostrazione, la sera stessa fu aperto il fuoco sulla folla che protestava in piazza Castello, e all'indomani i disordini proseguirono con saccheggi di negozi, redazioni di giornali e armerie. Il duro intervento repressivo, affidato al sottosegretario all'Interno Silvio Spaventa, provocò una cinquantina di morti. La folla scesa in piazza era eterogenea: impiegati, operai delle aziende statali, artigiani e manovali. Il comun denominatore era la paura di perdere il lavoro che la presenza del governo significava, urlando cori contro la città gigliata che a dire il vero non c’entrava nulla per quanto stesse accadendo. Anzi, i fiorentini accolsero il cambiamento con sentimenti contrastanti, tra orgoglio ma soprattutto timore per la perdita della propria identità storica.
Le preoccupazioni dei torinesi di diventare "periferia" del regno non erano infondate. Persi la corte, i ministeri, le ambasciate, la banca centrale e la zecca, la città subì un drastico calo economico-demografico. Gli ennesimi tumulti, scoppiati a Torino a fine gennaio 1865, persuasero infine Vittorio Emanuele II ad accelerare la partenza, che avvenne il 3 febbraio. Per la corte sabauda insediarsi a Firenze non fu difficile. Come residenza fu scelto lo storico Palazzo Pitti, già abitato dalle dinastie dei Medici e degli Asburgo-Lorena. Una sede che per magnificenza e ricchezza di arredi, per le pregiate opere d'arte sparse un po' ovunque e per il bellissimo giardino di Boboli, poco aveva da invidiare alle più belle regge d'Europa. I fiorentini invece rimasero tiepidi, non erano affatto contenti, avendocela a morte con i torinesi incolpevoli. Ciononostante anche intorno all’Arno iniziò un’operazione urbanistica, battezzata "il Risanamento" dai giornali dell'epoca, che si rivelò comunque un buon affare per molti. «Adesso Firenze è alquanto più rumorosa e variopinta, la folla nelle strade è enorme. Molta gente è affluita alla capitale.», scrisse Fedor Dostoevskij all'amico Nikolaj Strachov. Dopo circa sei anni, ciò che fu sancito un decennio prima, si avverò. I fanti e i bersaglieri italiani entrarono a Roma attraverso Porta Pia il 20 settembre 1870, e fu annessa al Regno d’Italia. La legge 3/2/1871, n.33, stabilì il trasferimento della capitale del Regno d’Italia da Firenze a Roma, evento che si realizzò il 1° luglio successivo.
Ovviamente la mia è stata una simpatica (spero) provocazione domenicale, come tempo fa vergai per juventini e partenopei: pur amando e rispettando la Storia, credo siano altre le vere cause che mai porteranno eufemisticamente ad un gemellaggio delle due squadre, quella dalla maglietta palata bianconera e l’altra a tinta unita di viola. Motivi ce ne sono e son tanti, che fanno parte ormai della storia sì, ma di quella del calcio e delle rivalità sane ed eterne del gioco che un tempo era il più bello del mondo. Partite leggendarie (la rimonta al Delle Alpi dallo 0-2 al 3-2 del 1994), risultati da pallottoliere (una Juventus del 1928 di Combi e Munerati ne fece 11 di reti senza subirne alcuna), gol fantastici (l’opera d’arte di Del Piero a scavalcare a volo Toldo), congiunture scudettate (il rigore della seconda stella di Brady), trofei vinti (la coppa Italia del 1960 con Charles mattatore e la Uefa del 1990 con Schillaci e Casiraghi), calciatori violabianconeri (Cuccureddu, Gentile, Torricelli, Di Livio, Chiesa, Chiellini, Vlahovic), e infine tradimenti consenzienti e mai, da ambo le parti, del tutto perdonati (Roberto Baggio).
Questi i motivi di uno che crede ancora, nonostante le imbarazzanti ultime Vecchie Signore, alle fiabesche sentenze emozionali impresse indelebilmente dal rettangolo verde.
Roberto De Frede

Iscritta al tribunale di Torino al n.70 del 29/11/2018
Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore responsabile Antonio Paolino
Aut. Lega Calcio Serie A 21/22 num. 178